
|
|
Piccolo navigatore palestinese
|

|
|
|
|
|
|
COME LEGGERE LA SCHEDA?
E' articolata in due momenti distinti:
- storico, affrontatando quindi l'occupazione storica di parte della Palestina;
- contemporaneo (tu sei qui, sezione Gaza!), nel presente dell'emergenza umanitaria in Palestina, legata a filo rosso allo
Stato di Israele.
|
|
|
|
|
|
STRISCIA DI GAZA,
OGGI |
|
Tra autodeterminazione e regime di controllo. |
La Striscia di Gaza, oggi, è imprigionata tra l’ autodeterminazione riconosciuta
dagli accordi di Pace dei primi anni ’90 (come descritti) e il
perdurare del regime di controllo israeliano sulla popolazione civile
palestinese.
In questa terra di Palestina, diversamente dalla West Bank, non
esistono insediamenti di popolazione da parte di Israele, che ha ritirato la
propria presenza solo nel 2005 attraverso un Piano di decolonizzazione portato avanti dall'allora Primo ministro Sharon, il quale, rinunciando a colonie in un lembo di terra ne rafforzava esistenza ed espansione in Cisgiordania. Eppure,
la presenza israeliana fuori dai confini della Striscia non ha smesso di
danneggiare le effettive potenzialità d’autodeterminazione palestinese. La situazione è stata resa ancor più grave da un
embargo durissimo imposto da Israele e sostenuto da USA e UE, a seguito
della vittoria elettorale di Hamas. Nessun
effetto rimarchevole ha prodotto l’alleggerimento delle misure di restrizione
del 2010 a seguito dell’uccisione da parte della marina israeliana di nove
attivisti turchi della Freedom Flotilla, intenti a forzare il blocco di Gaza via
mare.
Figura La Striscia di Gaza

Affronteremo gli impatti del controllo
israeliano della Striscia sul sistema infrastrutturale (elettricità, acqua,
casa), educativo, su quelli sanitario e alimentare, sul lavoro e in
particolare sulle possibilità d'occupazione in agricoltura e nella pesca. Tutto questo
con il sapore di una punizione collettiva, che - in forza
dell’ art. 33 della IV Convenzione di Ginevra
- è "crimine di guerra", con l’identificazione di criminale,
vittima e l’urgenza di risarcimenti. |
L’ Accordo di Gaza-Gerico del 1994, con il quale si realizzava il primo
trasferimento di poteri all’Autorità Nazionale Palestinese (Striscia di Gaza e
area cisgiordana di Gerico), prevedeva
34 che i confini della Striscia con Israele, a nord e a est, fossero
quelli della “Green Line” del 1948, a seguito del primo conflitto
arabo-palestinese. Al di qua della “Linea Verde” le autorità palestinesi
sarebbero state comunque responsabili della sorveglianza di un perimetro di
sicurezza che entrava nella Striscia per 1.000 metri.
Dalla seconda Intifada, a oggi, questa misura, che nasce da un accordo discutibile ma bilaterale, è sostituita da decisioni unilaterali prese in seno
al governo di Israele e volte a operare un controllo invasivo del territorio. Un
recente studio
35 dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari (OCHA) in
collaborazione con il WFP, agenzia ONU per l’alimentazione, ha mostrato – anche
attraverso indagini sul campo – l’esistenza di due aree di perimetro:
- Zona di non accesso, che va dalla Linea Verde a 500 metri: qui opera attivamente l’esercito israeliano, in violazione del diritto,
livellando coltivazioni e distruggendo ogni costruzione palestinese;
- Zona ad alto rischio di accesso, che va dai 500 metri dopo la Linea
Verde fino a 1.500 e in alcuni casi 3.000 metri: anche in questa zona opera
l’esercito israeliano attraverso incursioni e fuoco di avvertimento, tuttavia
senza sistematicità, lasciando la popolazione palestinese in un contesto
d’incertezza.
Le due zone così definite, sempre secondo lo studio delle Nazioni Unite, coprono quasi 65
chilometri quadrati, che in una “striscia” di terra ad altissima densità di
popolazione qual è Gaza, rappresentano il 35% delle sole aree coltivabili.
Per l’industria agricola il livellamento della terra significa soprattutto lo
sradicamento degli alberi da frutta. La politica unilaterale d'incursione nella Striscia di Gaza con elicotteri, droni e schiacciasassi ha significato così una perdita di oltre 150 milioni di euro (costo di
ricostruzione) solo per quanto riguarda la distruzione di ulivi, mandorli,
alberi da agrumi, vigneti e altri alberi da frutta, senza quindi contare il
livellamento delle altre strutture civili (case, pozzi d’acqua, fattorie, etc.).
Contro queste pratiche illegali i coltivatori palestinesi
hanno cercano di opporre un'agricoltura di sussistenza, rinunciando alla
ri-coltivazione di alberi da frutta, scegliendo colture a ridotte esigenze di
cura durante l’anno e resistenti alle operazioni di livellamento in quanto non
più alte di 80 cm: si tratta tuttavia di colture meno profittevoli e proteiche,
come grano e orzo.
Ciò trasforma inevitabilmente anche il paesaggio della Striscia di Gaza, ed è
quanto visibile utilizzando le immagini satellitari storiche
della piattaforma Google Earth. Puntando sull'area rurale di Beit Hanoun
(Bayt Hanun),
nella prossimità della Linea Verde di armistizio del 1948, ad esempio, il confronto tra un’immagine scattata il 21 gennaio 2004 e un’altra
il 23 agosto 2011 deve lasciare spazio a ulteriori indagini.
Figura L'area agricola di Beit Hanoun,
2004 (via
Google Earth)
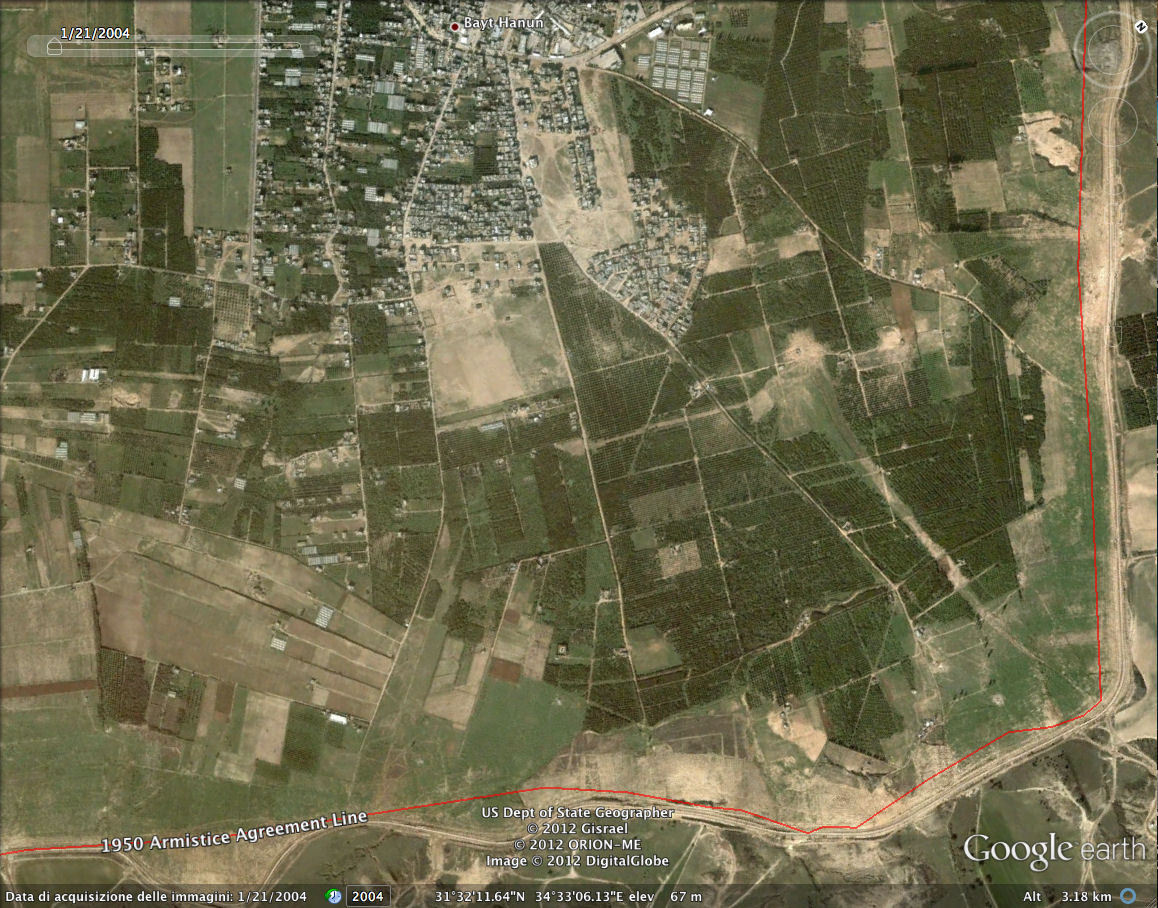 2004
Figura L'area agricola di Beit Hanoun,
2011 2004
Figura L'area agricola di Beit Hanoun,
2011 (via
Google Earth)
 2011 2011
Israele può mantenere tal regime discrezionale di accesso alla terra solo
grazie alla propria macchina militare, dispiegata lungo tutto il confine con la
Striscia, fatta anche di torrette controllate da remoto che custodiscono
mitragliatrici i cui proiettili possono raggiungere 1.500 metri di distanza, causa di
decine di ferite registrate fra la popolazione civile al di
qua della Linea Verde
36 (nella cosiddetta "buffer zone", la zona cuscinetto dichiarata
unilateralmente da Israele all'interno del perimetro palestinese).
Il perdurare della stretta israeliana sulla Striscia di Gaza, nei termini appena
detti, determina una forte erosione del reddito familiare dei civili palestinesi
che vivono ogni giorno le restrizioni. Taluni abbandonano la propria terra in
direzione di diverse strategie di reddito: raccoglitori di macerie e detriti,
alla luce del parziale blocco all’importazione di materiali edili per la
ricostruzione, oppure operai nell’industria dei tunnel per e verso l’Egitto, per
l’importazione di materiali soggetti a embargo o carenza. Coloro i quali
scelgono di non abbandonare la propria attività, rinunciano al proprio terreno
acquisendo in affitto altra terra in aree più sicure – talvolta solo per
ottenere prodotti necessari al consumo domestico.
Le 75.000 tonnellate di prodotti agricoli perse ogni anno, per un valore
economico di poco inferiore ai 50 milioni di euro, comportano anche conseguenze
via-via più profonde nella qualità della vita dei civili, e non solo
di quelli che hanno o avevano terreni nelle aree ad accesso ristretto. Il 44% di
tutti gli abitanti della Striscia vive in un regime di deficit alimentare
37 e le insufficienze nutritive legate al sovra-consumo di cibi ricchi
di carboidrati quali zucchero e cereali, meno costosi rispetto a quelli delle colture proteiche, sono poi la correlazione all’aumento di anemia tra
minori, del diabete e delle malattie legate alla pressione sanguigna
38.
|
L’80% dei palestinesi della Striscia di Gaza dipende così dagli aiuti umanitari 39. Ciò
si deve in gran parte al regime di accesso controllato da Israele alle fonti di
reddito economico e approvvigionamento alimentare, ovvero la terra, ma pure la
striscia di mare che bagna le coste di Gaza.
Il già citato Accordo Gaza-Gerico
del 1994 prevede all' articolo 11
venti miglia nautiche, pari a oltre 35 chilometri dalla costa della Striscia,
anche per le comuni attività marittime – tra cui la pesca. Imbarcazioni
israeliane, dal dettato dell’accordo, possono navigare nelle acque palestinesi, e
senza limitazioni, se non l'obbligo di coordinamento con le autorità marittime
della Striscia di Gaza.
Oggi come ieri, niente di tutto questo è attuato, a vantaggio di un
regime discrezionale e unilaterale posto da Israele e dai suoi governi: con episodici alleggerimenti 40, il
perimetro marittimo in vigore dal gennaio 2009 e cioè dall’operazione militare “Piombo
Fuso” è stato di 3 miglia nautiche, rispetto alle 20 dell’Accordo del 1994. La misura, quasi come una marea politica nelle mani di Israele, subisce nel tempo estensioni e restrizioni dalle 3 alle 15 miglia nautiche.
Nel primo mese di alleggerimento della misura restrittiva (Novembre 2012), che ha portato le miglia nautiche navigabili da 3 a 6 – comunque meno di 1/3 di quelle sancite dall’Accordo bilaterale, il pescato è aumentato del 46%, una percentuale scesa all’8% nel mese successivo 41.
Figura Le acque navigabili dai pescatori della Striscia di Gaza
Trad. e elaborazione propria a partire da cartina delle Nazioni Unite OCHA oPT
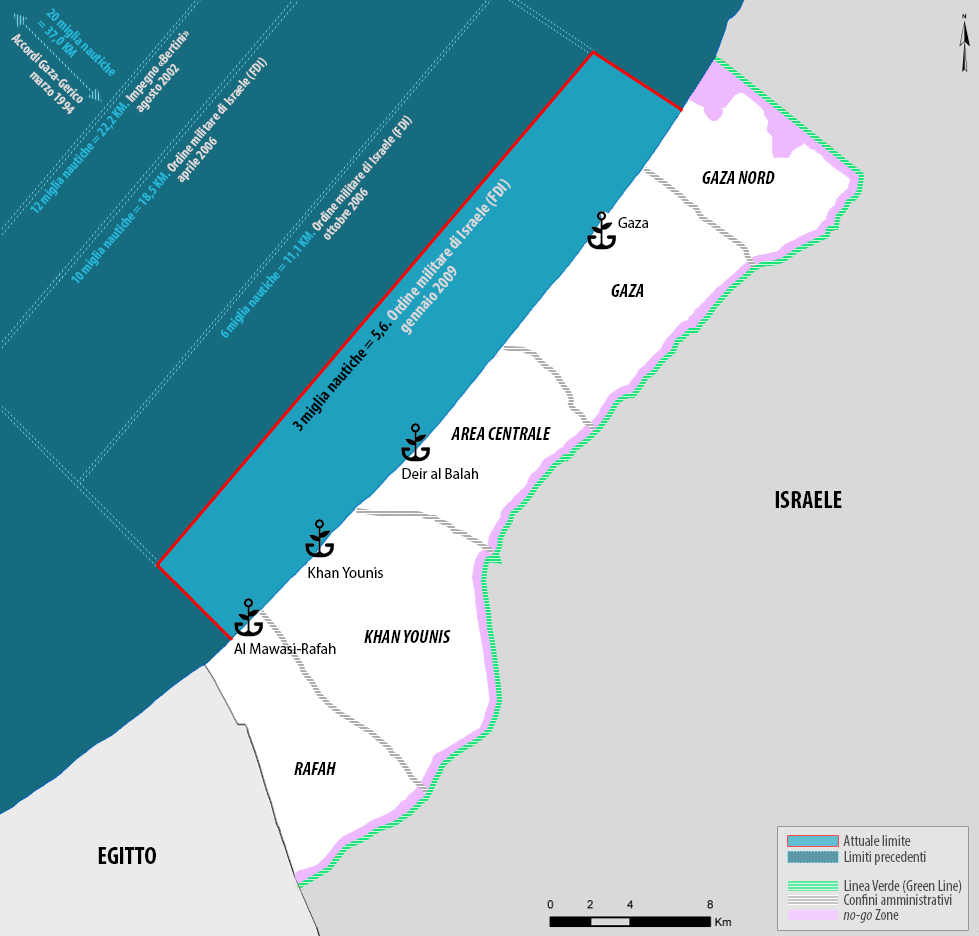
L’erosione di acque liberamente navigabili non è senza un impatto decisivo
nella qualità della vita dei cittadini palestinesi:
- in termini di lavoro, di occupazione
Prima della Seconda Intifada del 2000 (il moto di ribellione
popolare palestinese) il Ministero dell’Agricoltura della Striscia registrava
oltre 10.000 licenze – necessarie per la libera navigazione, già dall’Accordo Gaza-Gerico del 1994; gli ultimi dati disponibili, aggiornati al 2009, attestano
il valore delle licenze a 3.500 (-65%) 42, con una perdita di occupazione anche per
l’indotto dell’industria ittica che solo oggi dà lavoro a circa 2.000 persone 43.
L’assenza di un canale di comunicazione ufficiale tra i pescatori palestinesi e
Israele, che ha arbitrariamente decretato l’erosione per l’85% delle acque
navigabili, e quindi della possibilità di lavoro, abbandona i primi al rischio
continuo del fuoco israeliano, della detenzione amministrativa nelle carceri e
della confisca dell’unica fonte di reddito, l’imbarcazione.
- in termini alimentari
Si assiste a una riduzione della disponibilità di pescato raccolto
da imbarcazioni palestinesi che transitano nei porti di Rafah, Khan Younis, Deir
al Balah e Gaza: erano 3.650 le tonnellate di pesce alla fine degli anni
’90 (1999), mentre dieci anni più tardi (2009) superano di poco 1.500 44. Ciò
comporta strategie alternative per la sopravvivenza, come l’importazione di
pescato da Israele e dall’Egitto (legale o “illegale” - attraverso la rete di
tunnel o il rischioso approdo nei porti egiziani). Dati che fanno specie se si
guarda la cartina della Striscia di Gaza e al suo essere bagnata dal mare per
tutto il lato ovest di confine del territorio.
Inoltre, la possibilità di pesca limitata alle acque più basse (non oltre 3 miglia nautiche) limita
anche varietà e qualità di pescato, oltre alla quantità: così muore la raccolta
del tonno nell’industria ittica palestinese, e nel raccolto delle sardine (che
rappresentano il 70% del pescato) si concentrano i pesci più piccoli, non
potendo raggiungere il meglio della migrazione di questa specie verso le acque
turche, dal Nilo, all’altezza delle 10 miglia nautiche. Tutto questo implica un
declino nella qualità del raccolto e quindi del suo valore economico.
Di più e più largamente, a seguito della crisi energetica di cui si dirà, anche le
acquacolture (che richiedono un’energia-che-non-c’è per l’ossigenazione e il trattamento dell’acqua) hanno perso e continuano a perdere ogni mese
tonnellate di prodotto 45, con un deficit complessivo e aggregato che può lasciar
parlare di emergenza alimentare.
- in termini ambientali
La concentrazione delle attività marittime in acque più basse causa un
danno
all’ecosistema, anche attraverso la necessità dell’utilizzo di reti a maglie più
strette per la cattura dei più piccoli esemplari di sardine.
C’è un altro e ultimo aspetto, ed è quello legato allo sfruttamento delle risorse energetiche a
largo della Costa di Gaza. Nel gennaio del 2009 Michel Chossudovsky di
Globalresearch e già nel luglio del 2007 l’italiana Debora Billi avevano ricordato come a largo della
Striscia di Gaza fosse stato rinvenuto nel 1999 un giacimento di gas naturale,
che con il suo abbondante miliardo di piedi cubi di gas potrebbe soddisfare la
domanda energetica palestinese per 15 anni 46. Il 50% dei profitti del gas, se mai
commercializzato, finirebbe nelle casse dell’Autorità Nazionale Palestinese e il
restante sarebbe condiviso tra il gruppo britannico British Gas (BG), la
Consolidated Contractors Limited (CCC) e la società pubblica palestinese
Palestine Investment Fund (PIF).
Tuttavia, per sfruttare le riserve naturali a
largo di Gaza è necessario un investimento infrastrutturale da parte
del British Gas Group, che ha licenza venticinquennale per operare sui due
giacimenti di gas: l’investimento, allora, secondo logiche di mercato, non può
essere senza un preventivo contratto a lungo termine per la vendita del gas.
Qui, interviene la politica di Israele: dapprima partecipa ai negoziati
trattando un prezzo di vendita per piede cubo fuori dalle logiche di mercato,
per poi negare la propria autorizzazione politica di sicurezza alla vendita del
gas in altri mercati 47, come riporta in un recente articolo
Victor Kattan,
consigliere giuridico per il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo a
Gerusalemme Est. Il gas palestinese, infatti, potrebbe essere efficacemente
commercializzato anche al di là del Medio Oriente, come in Giappone e Corea del
Sud, dopo essere stato condensato in appositi impianti presenti in Egitto, tra
cui quello dell’italiana Agip. La politica israeliana, tuttavia, se non
efficacemente contrastata, impedisce ciò, e la limitazione dello spazio
navigabile ha il sapore di sequestro del gas
palestinese, arma di ricatto in mano ad Israele.
|
A ulteriore danno dell’industria ittica e soprattutto della sicurezza
alimentare dei cittadini palestinesi, ogni giorno circa
90 milioni di litri di liquame non viene trattato ma direttamente
scaricato nell’ambiente e principalmente nel Mar Mediterraneo 48 o nel
“lago” Beit Lahiya (erano 80 solo un anno prima 49).
Ciò comporta un’urgenza in termini di sicurezza
alimentare (a causa della contaminazione del pescato) e profondi danni
alle falde acquifere di Gaza, dove si registra - oltre a uno dei più
bassi consumi di acqua al Mondo, sotto ogni standard di sicurezza -
anche l’aumento di disturbi quali diarrea, infezioni alla pelle,
attacchi parassitari e anemia. Il 90% dell’acqua estratta dalle falde di Gaza è così non potabile 50, comportando o l’acquisto di desalinatori o il più costoso rifornimento mediante botti.
Urgenze, queste, che richiedono forti e tempestivi investimenti di
capitale per assicurare un adeguato trattamento
degli scarichi fognari. Tuttavia, di nuovo, interviene Israele e una
politica di controllo e limitazione all’autodeterminazione palestinese:
questa volta attraverso il complesso sistema di approvazione e controllo
dell’esecuzione dei progetti internazionali umanitari, volti a innovare
il sistema infrastrutturale della Striscia.
Uno dei più grandi progetti
nel settore, approvato nel 2004 dalla Banca Mondiale e finanziato - tra
gli altri - dalla Commissione Europea e da agenzie francesi e svedesi,
per un totale di 43 milioni di dollari d’investimento, è il “ Northern
Gaza Emergency Sewage Treatment” ( NGEST).
Dall’ultimo report 51, del 21 luglio 2012, si legge:
[...] Continua a essere critico il mantenere uno stretto
coordinamento con l’unità delle Forze di Difesa Israeliane per le
attività civili (“COGAT”), per garantire consegne prevedibili e
tempestive dei beni e delle materie prime, così come l’arrivo dei
collaboratori esterni attraverso il confine israeliano, al fine di
evitare i gravi ritardi e sovraccosti che hanno afflitto l’attuazione
della fase A (ndr: oggi completata e che aveva l’obiettivo di mitigare
le urgenze delle comunità attorno al lago Beit Lahiya). [...]
Un’interruzione dei lavori richiesta dalle Forze di Difesa Israeliane
con un preavviso molto breve e perdurata per più di una settimana è un
esempio calzante.
Altro esempio è l’interruzione dei lavori per dieci mesi 52, dal giugno del 2007 al marzo
del 2008. Eppure, l’urgenza umanitaria era già stata rappresentata
dall’ alluvione di un villaggio ai margini del lago di scarico Beit
Lahiya, che causò 5 morti e 25 feriti 53.
Altri progetti in essere, finanziati dall’ Agenzia giapponese per la
cooperazione internazionale e dalla Banca per lo sviluppo KfW
hanno riscontrato simili ritardi e conseguente aumento dei costi.
La crisi energetica, di cui si dirà a breve, che rende malfunzionanti le infrastrutture di pompaggio delle acque reflue, determina essa stessa la deviazione degli scarichi in fragili laghi d’emergenza: così, anche il 13 novembre 2013, 35.000 metri cubi di scarichi non trattati hanno allagato un’area del quartiere di Az-Zeitoun, a sud di Gaza, esponendo oltre 3.000 persone a rischi sanitari 54.
|
La Striscia di Gaza, inoltre, non è autosufficiente in termini di energia elettrica, anche
a causa della distruzione delle principali infrastrutture nel 2006 durante il
primo bombardamento aereo israeliano della Striscia, operazione militare cui gli israeliani hanno dato il nome di
“Piogge estive”, rappresaglia al sequestro del soldato israeliano Gilad
Shalit.
Così, l’utilizzo d’energia elettrica - momento cruciale nello sviluppo delle
popolazioni - è soggetto a forti restrizioni, con ricorrenti black-out
(programmati e non) che possono durare sino a 12 ore 55.
La domanda interna attuale di 360 megawatts è infatti assorbita solo per il 22%
dall’impianto di Gaza (80 megawatts), e gli acquisti di energia dall’Egitto (6%)
e soprattutto dalla Israel’s Electricity Company (33%, pari a 120 megawatts) non
sono sufficienti a rispondere alle pur ridotte necessità palestinesi. Inoltre,
proprio i 120 megawatts acquistati ogni anno dalla compagnia israeliana passano
per torri elettriche situate nella “no-go zone”, a 10-20 metri dalla Linea Verde
di confine, rendendo necessario - in caso di intervento manutentivo - il
coordinamento con le unità dell’esercito israeliano, reticenti al fine di
posticipare il termine del malfunzionamento o black-out 56.
Generatori di corrente a benzina o diesel sono una soluzione emergenziale al
deficit, applicata soprattutto là dove è indispensabile, come negli
ospedali. Tuttavia, la difficoltà di approvvigionamento e la carenza di
carburante, per l’embargo imposto da Israele, rende tale applicazione una
non-soluzione, rideterminando - in caso di black-out - il rischio di
deterioramento di materiali medici, sangue, nonché l’interruzione e il ritardo
di operazioni urgenti 57.
La crisi energetica è stata ulteriormente aggravata, prima, dalla chiusura o distruzione dei tunnel da e verso l’Egitto – per i quali passava una quota di combustibile di contrabbando 58, e poi, durante l’ultimo assedio israeliano della Striscia (luglio 2014), dal bombardamento della centrale elettrica di Gaza.
Figura La Striscia di Gaza e la dipendenza energetica da Israele
Traduzione in italiano della cartina di Sabbah Report
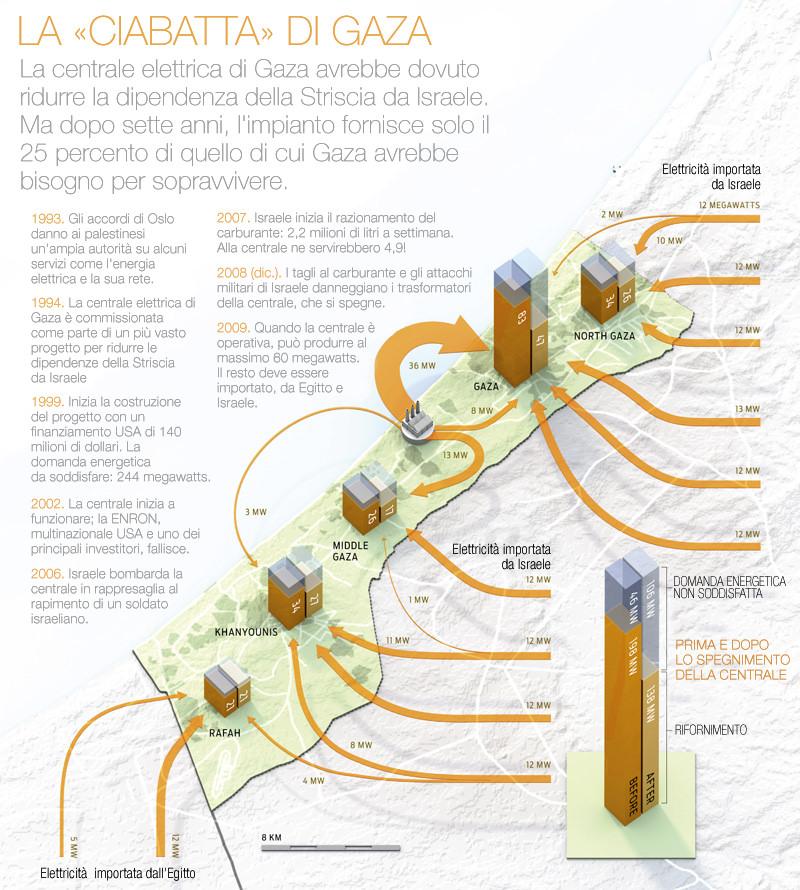
|
Una delle più immediate conseguenze educative del regime di controllo israeliano
della Striscia è la riduzione della vita scolastica a Gaza, a vantaggio di un
ingresso prematuro nel mondo del lavoro 59 che coincide quasi sistematicamente con
i 18 anni 60:
è una delle strategie di sopravvivenza alla crescente disoccupazione
all’interno delle famiglie, non esaustivamente ma anche a causa delle politiche
di controllo della terra e delle acque marittime di cui si è detto.
Per chi rimane, la locuzione chiave è “ assenza di strutture”. I
bombardamenti, specie durante l’operazione militare “Piombo Fuso” (2008), hanno
distrutto 18 scuole e nidi per l’infanzia 61 (di questi, nel 2010/2011 se ne
registravano 782, di cui solo 2 pubblici, per 60.134 bambini 62), danneggiandone
250. Le difficoltà per la ricostruzione, a causa della carenza di materiali
edili unita agli ostacoli posti da Israele ai progetti umanitari internazionali,
conducono il sistema educativo palestinese a realtà di sovraffollamento,
cancellazione delle attività non strettamente educative e scolastiche, riduzione dell’orario
di funzionamento per sezione o classe, precaria
protezione dagli elementi atmosferici, sintomi psicologici che richiamano ansia,
trauma, difficoltà permanente di concentrazione - specie per quelle strutture
situate in prossimità della Linea Verde che ospitano circa
4.400 bambini soggetti al frequente udito dei colpi di arma da fuoco, anche
direttamente
contro le scuole 63.
I bombardamenti dei due assedi militari dopo Piombo Fuso (Pilastro di Difesa nel 2012 e Margine di protezione nel 2014), hanno prodotto ulteriori danni alle già carenti strutture scolastiche e pre-scolastiche: quasi la totalità dei 460.784 studenti palestinesi frequentano scuole primarie e secondarie (396 pubbliche, 244 a gestione UNRWA e 48 private) che lavorano a turni doppi, e in alcuni casi con sezioni di oltre 50 studenti 64.
Solo oggi mancano circa 250 scuole per accogliere degnamente i quasi 500mila studenti palestinesi: nel 2020 ne serviranno altre 190, per un totale di 440 nuove scuole per oltre 650mila ragazzi e ragazze 65. Un’operazione minata da bombardamenti di strutture esistenti e dall’embargo dei materiali edili per costruzioni civili.
L’educazione diventa così l’area di sviluppo potenziale nella quale l’assedio quotidiano di Israele su Gaza è più pressante, ma allo stesso tempo più difficilmente misurabile nelle conseguenze sulla popolazione, che di fronte a vuoti educativi potrebbe trovare rifugio nell’estremismo e nel dogmatismo religioso.
Un recente articolo di Asmaa al-Ghoul su Al-Monitor raccoglie un’intervista al proprietario della prima biblioteca di Gaza, aperta nel 1942:
In passato i libri arrivavano da Gerusalemme; la nostra libreria era fornita di giornali e riviste. Nel 1946, comunque, il capo della distribuzione al Cairo decise che la mia libreria – Al-Hashimia – sarebbe stata la distributrice certificata per la Striscia di Gaza. Giornali e libri arrivavano quotidianamente via treno dall’Egitto. C’erano molto progetti culturali ed educativi, interrotti dall’occupazione israeliana; hanno chiuso tipografie, arrestato i tipografi e imposto una tassazione elevata al settore. Ciò fu fatto con l’obiettivo di rendere e mantenere deculturata la popolazione.
 24 novembre 2012, primo giorno di scuola dopo la tregua tra Israele e Hamas: le bambine palestinesi sono circondate dalle macerie di una scuola di Gaza City danneggiata dai bombardamenti israeliani. (AP Photo/Bernat Armangue).
24 novembre 2012, primo giorno di scuola dopo la tregua tra Israele e Hamas: le bambine palestinesi sono circondate dalle macerie di una scuola di Gaza City danneggiata dai bombardamenti israeliani. (AP Photo/Bernat Armangue).
|
La popolazione stimata alla fine del 2012 nella Striscia di Gaza era pari a 1.672.865, con 4.583 abitanti per chilometro quadrato.
Solo la naturale crescita demografica della popolazione richiede allora uno sforzo
per la costruzione di almeno 25.000 unità abitative, cui tuttavia vanno ad
aggiungersi:
- 6.300 unità distrutte per bombardamenti durante l’operazione
militare israeliana “Piombo Fuso”;
- 2.900 unità distrutte per bombardamenti durante le precedenti azioni militari israeliane;
- 5.500 unità per superare i pur minimi standard di sicurezza abitativa nei
campi profughi della Striscia di
Gaza (al 1° gennaio 2012 la UNRWA ha registrato 1.167.572 rifugiati in 8 campi).
Il settore edile, nell’industria palestinese, è quindi quello che più
potrebbe beneficiare di un alleggerimento del blocco imposto alla Striscia di
Gaza da Israele, anche attraverso la collaborazione in progetti internazionali
di costruzione, rimanendo fermo il blocco all’importazione nazionale di
materiale edile per la (ri)costruzione. Ciò è solo in parte avvenuto, a causa
della rallentante politica israeliana di autorizzazione 66 dei progetti e -
all’interno di un progetto approvato - di monitoraggio di ogni movimento di
materiale, esattamente come già visto nell’esempio delle infrastrutture per il
trattamento delle acque reflue.
L’ urgenza del problema della casa, per migliaia di civili palestinesi, è
inoltre solo in parte mitigata da due strategie di sopravvivenza per
l’approvvigionamento di materiale di (ri)costruzione:
- il rafforzamento del mercato di materiale edile contrabbandato attraverso gli stretti
tunnel 67 da-e-per
l’Egitto, che tuttavia non può accogliere - per ragioni logistiche -
materiali e beni quali bitume, barre di acciaio, cemento per la costruzione di
tegole, etc.;
- l’invenzione di un nuovo lavoro (spesso dopo aver perso quello
nelle terre o nelle acque marittime), ovvero il raccoglitore di macerie e detriti
poi lavorati e trasformati in aggregati edili, pur tuttavia di scarsa qualità.
Una situazione così delineata, riassumibile nella difficoltà di rispondere
alla domanda di strutture abitative per la popolazione civile palestinese,
conduce a radicamenti negativi nella qualità della vita 68:
- il sovraffollamento degli spazi domestici minaccia la privacy di ogni individuo all’interno della famiglia, con un effetto
sulla società palestinese che - assieme alla disoccupazione crescente dell’uomo
- alimenta una questione di genere;
- edifici sotto gli standard di sicurezza
significano soprattutto scarsa protezione dall’ambiente circostante, e pertanto
costi per un sistema sanitario già in precario equilibrio;
- le carenze abitative, unite alle carenze di strutture educative, producono un doppio
sovrappopolamento degli spazi che mina i risultati scolastici di generazioni di palestinesi
della Striscia.
|
"Prendi dei gattini, dei teneri micetti e mettili dentro una scatola", mi dice
Jamal, chirurgo dell’ospedale Al Shifa, il principale di Gaza, mentre un
infermiere pone per terra dinnanzi a noi proprio un paio di scatoloni di
cartone, coperti di chiazze di sangue. "Sigilla la scatola, quindi con tutto il
tuo peso e la tua forza saltaci sopra sino a quando senti scricchiolare gli
ossicini, e l’ultimo miagolio soffocato".
Fisso gli scatoloni attonito, il dottore continua. "Cerca ora di immaginare cosa accadrebbe subito dopo la
diffusione di una scena del genere, la reazione giustamente sdegnata
dell’opinione pubblica mondiale, le denunce delle organizzazioni animaliste..."
Tanto valeva nascere animali, piuttosto che palestinesi, saremmo stati più
tutelati?"
(Vittorio Arrigoni)
Tra il 27 dicembre 2008 e il 18 gennaio 2009, in tutto il mondo
occidentale le cronache dell’ assedio militare israeliano della Striscia di Gaza
hanno oltrepassato – senza nulla dire – il muro del silenzio giornalistico sul
peso quotidiano della presenza di Israele in Palestina, che fin qui si è cercato
di descrivere.
Per questo non percorreremo più i terribili giorni dell’offensiva militare
israeliana nella Striscia
69. Però, è necessario rimettere in
piedi alcuni dati e alcune parole:
- Nel dicembre del 2008 Israele ha lanciato una guerra preventiva al
movimento politico e paramilitare che amministrava la Striscia di Gaza dal 2006,
“Hamas”, ma soprattutto ai civili palestinesi;
- In otto anni, dal giugno 2004
al novembre del 2012, i razzi e i mortai lanciati dalla resistenza palestinese
dalla Striscia di Gaza su Israele hanno fatto 24 morti
70 in oltre 3.000 giorni (il dato esclude i primi anni della
Seconda intifada e forme di attacco diverse);
- In 20 giorni (20) l’assedio israeliano sulla Striscia di Gaza, la guerra
preventiva, ha fatto 1.397 morti 71, 764 dei quali (54,69%) estranei all’impari
conflitto e 345 bambini (24,70%), come i 40 morti per il bombardamento di una
scuola UNRWA adibita a rifugio ONU 72; 9 (nove) gli israeliani uccisi dai
palestinesi durante i 20 giorni di assedio;
- I bombardamenti israeliani,
secondo il bilancio della Croce Rossa Internazionale, hanno prodotto la
distruzione della casa per 80.000 palestinesi 73;
- L’organizzazione israeliana
“Breaking the silence”, critica nei
confronti dell’occupazione, ha prodotto un carnoso rapporto nel quale
viene denunciata la disumanizzazione e la nulla considerazione per il destino
dei civili palestinesi durante l’assedio militare 74, attraverso la
raccolta di testimonianze anonime di soldati nelle fila delle Forze di Difesa
Israeliane;
- Israele ha utilizzato fosforo bianco durante il conflitto contro
la popolazione civile, come è stato documentato da più organizzazioni; al di là di chi contesta l’esistenza del divieto all’uso
del fosforo bianco nella “Convenzione su certe armi convenzionali”,
il contatto con quest'arma provoca profonde ustioni che penetrano la pelle,
lasciando in chi sopravvive alti livelli di tossicità a causa delle sostanze
prodotte durante la reazione con il corpo umano, oltre ai residui
incombusti.
Il 7 maggio 2012 l’International
Journal of Environmental Research and Public Health ha pubblicato una ricerca
scientifica 75, a firma di un’equipe palestinese e italiana (Università di Genova
e Napoli). Dai dati raccolti, su un campione di 4.027 parti, 55 sono i bambini
nati con difetti congeniti (“birth defect”), ovvero 14 su 1.000. Ai genitori
è stato
chiesto se fossero o meno stati esposti al fosforo bianco: quasi 3.000 nuclei
(2.977) hanno risposto alla domanda.
Ne è emerso che il 27,2% dei genitori (uno
o entrambi) di bambini affetti da problemi genetici sono stati esposti al
fosforo bianco – 12 su 44, mentre appena l’1,7% – 49 su 2.933 – sono nati sani
nonostante l’esposizione di uno o entrambi i genitori alla sostanza 76.
Questa
significativa differenza suggerisce un “ruolo causativo/favorente
dell’esposizione acuta dei genitori alle contaminazioni delle armi non
convenzionali […] sullo sviluppo embrionale dei propri figli”.
A Piombo Fuso è seguito, nel 2012, un altro assedio militare, “ Pilastro di Difesa”: 174 morti, di cui 101 civili, 14 donne e 36 bambini; 1.046 feriti, di cui 446 bambini, disabilità prodotte dallo Stato di Israele che richiederanno cure in ospedali già carenti di energia elettrica come di farmaci 77.
L’assedio del luglio 2014 sulla Striscia, l’operazione “ Margine di Protezione”, allunga la scia di distruzione del popolo di Palestina: in meno di un mese di bombardamenti l’operazione israeliana ha superato Piombo Fuso nel numero di vite interrotte, 1.439 al 1° agosto, 926 civili (64,35%), di cui 286 bambini e 187 donne.
Come in Genet, il “movimento palestinese rimette in discussione l’arcaismo di
certe società”. Eppure per scongiurare un radicamento profondo nella
contemporanea cultura palestinese dell’Islam nella sua forma “giuridica, intransigente e retrograda” 78, prodotto storico della colonizzazione
europea, è urgente non già un processo di pace ma di decolonizzazione.
La
stretta quotidiana su Gaza, che poi cresce fino ad assedi medievali, al contrario, spacca la comunità palestinese, da sempre madre di una
logica di libertà confessionale, producendo la pur debole resistenza armata con
i “razzi-islamici” di Hamas, l’unico gruppo capace di organizzarsi militarmente
in una resistenza che è Resistenza, e non “resistenza islamica”.
|
La Palestina non è solo la Striscia di Gaza. Eppure, per i
palestinesi della Striscia, la Cisgiordania è un mondo difficilmente
accessibile, e l’alleggerimento del blocco nel 2010 non ha prodotti risultati
confortanti 79 in tema di libero movimento della popolazione.
Dal settembre 2000, con l’avvio della Seconda Intifada, infatti, uscire dalla
“prigione” di Gaza richiede un permesso speciale assieme al lento
attraversamento di valichi, anche se per motivi sanitari (specie verso le
strutture medico-specialistiche di Gerusalemme est), di studio (per tirocini in
ospedali della West Bank, per frequentare facoltà non presenti nella Striscia 80) o
di ricongiungimento con familiari residenti in Cisgiordania.
Un paziente su cinque manca il proprio appuntamento in un ospedale della
Cisgiordania a causa del rifiuto del permesso o di un ritardo nella concessione 81. Nel 2010, inoltre, sono stati concessi appena 3 (tre) permessi di studio in
università cisgiordane.
Ci stiamo così per spostare, nella trattazione, da due terre di Palestina (da
Gaza verso la Cisgiordania) eppure in un modo agevole sconosciuto ai palestinesi.
(La drammatica foto di "copertina" è di Eva Bartlett del blog " In Gaza").
|
|
|
 | |


 Un sito antifascista
Un sito antifascista


 Un sito antifascista
Un sito antifascista